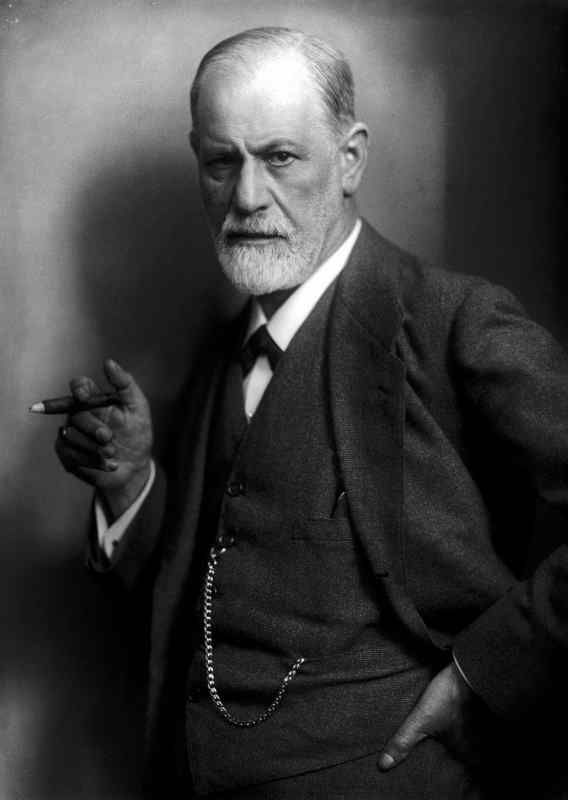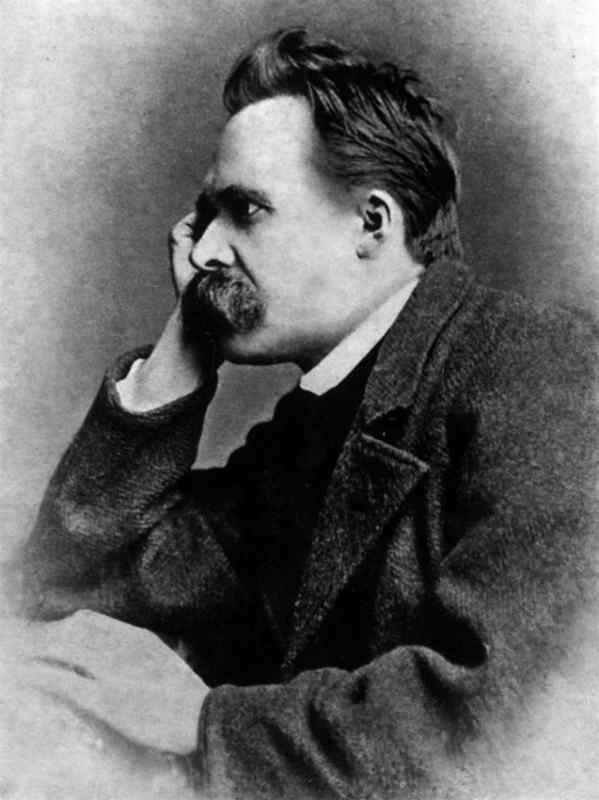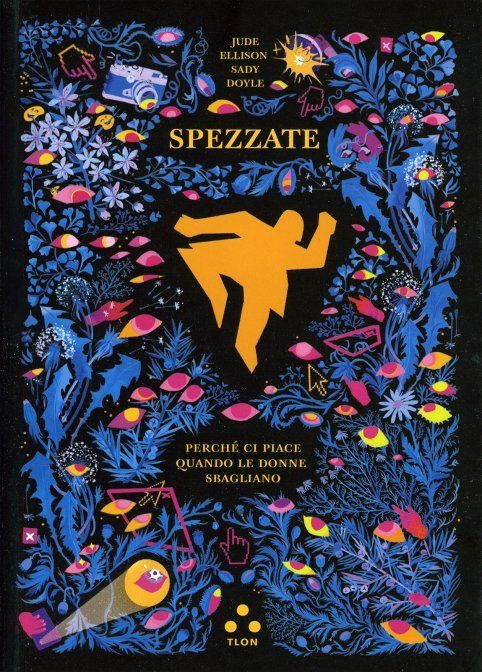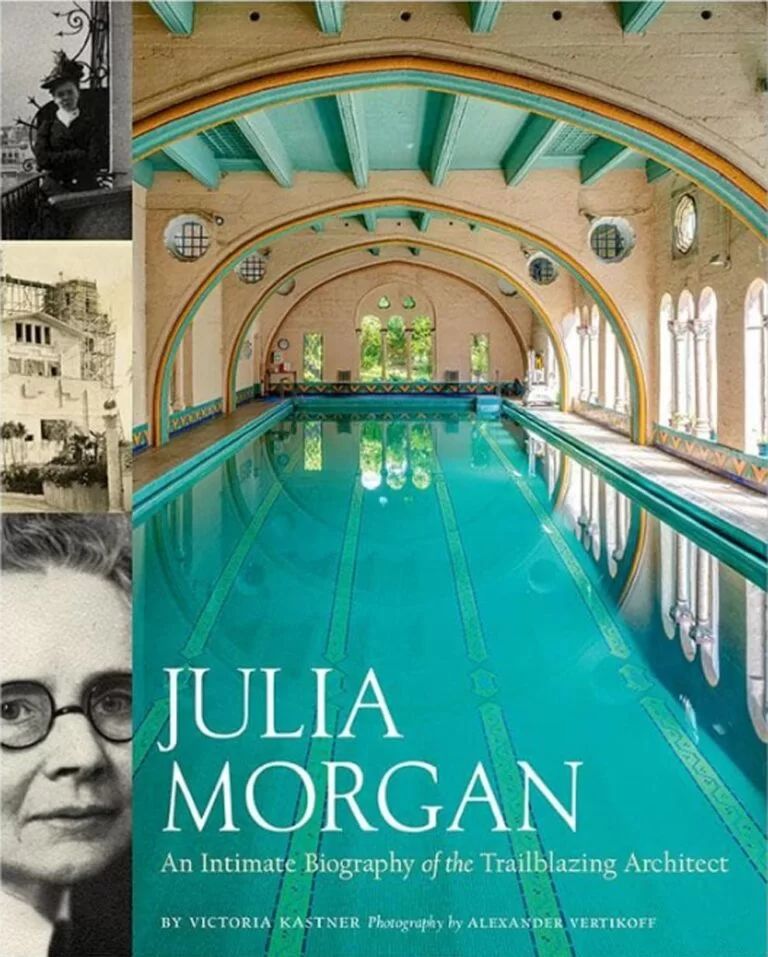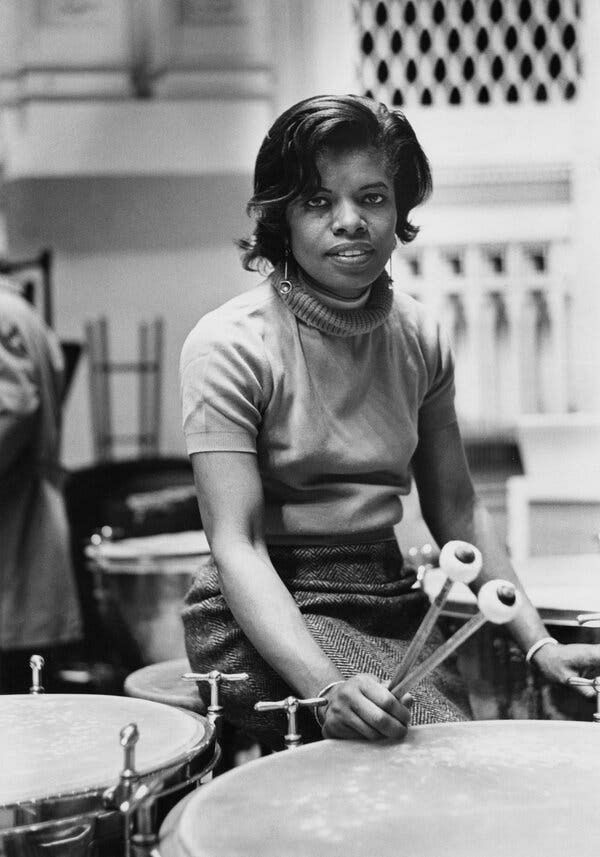La storia della protagonista del film, progressista e femminista, è ispirata a quella della figlia di Ber Borochov, tra i teorici del sionismo socialista, ‘convinto che arabi e israeliani potessero convivere in Palestina’.
L’ultimo film di Michael Winterbottom, che si intitola Shoshana, è stato presentato in prima mondiale a Toronto, ed è un thriller politico che racconta una vera storia avvenuta nella Palestina occupata dagli inglesi negli anni Trenta, prima della nascita di Israele, e che “affronta il modo in cui l’estremismo politico e la violenza creino una separazione tra le persone costringendole a scegliere da che parte stare”.
Le vie del cinema sono imperscrutabili: il film del regista inglese esce nel pieno della attuale fase dell’interminabile guerra tra Israele e i suoi nemici, scatenata dall’attacco di Hamas di oltre 8 mesi fa. Il tempismo può apparire sospetto, vista la inusuale prospettiva storica prescelta, ma in realtà il progetto di questo film risale – sembra – al 2007, anno in cui il cineasta aveva partecipato al Jerusalem Film Festival.
Si tratta, in ogni caso, di una uscita nelle sale (dal 27 giugno con Vision Distribution) quanto mai opportuna per fare chiarezza sulle origini di tanto odio e distruzione generati dal secolare dramma dell’ebraismo.
La vicenda, infatti, è collocata nella Palestina sottoposta al mandato britannico, una sorta di protettorato che gli inglesi si attribuirono nello scacchiere del colonialismo internazionale sulla base della “Dichiarazione Balfour”, dal nome del ministro degli esteri di Sua Maestà che – nel pieno della I guerra mondiale, combattuta contro gli Imperi centrali tra cui quello Ottomano – si era impegnato ad assicurare agli ebrei un “focolare nazionale”, ovvero una patria dove raccogliere la diaspora millenaria del popolo di Jahvè.
Questo progetto, volto a realizzare le aspirazioni del sionismo, suscita l’entusiasmo e la voglia di partecipazione alla costruzione dello Stato d’Israele in tanti giovani provenienti soprattutto dall’Europa centro-orientale: tra questi la protagonista Shoshana (Irina Starshenbaum), una giovane giornalista ucraina di famiglia progressista, che si trasferisce nella sempre moderna Tel Aviv.
Qui Shoshana frequenta attivisti e intellettuali ebrei come lei, con i quali condivide il sogno di uno Stato socialista dove vivere in pace con gli arabi che vivono in terra di Palestina. Peccato, però, che quel sogno resterà tale, anche perché proprio negli anni in cui si sviluppa la vicenda (dal 1938 al 1940) all’aggravarsi dell’antisemitismo in Europa – culminato con l’aggressione nazista alla Polonia – corrisponde la nascita di gruppi paramilitari ebraici, intenzionati ad imporre con la violenza la creazione del loro Stato.
L’Irgun, un gruppo clandestino dedito al terrorismo, compie numerosi attentati dinamitardi sia contro civili arabi, sia contro membri dell’esercito britannico, considerato dagli oltranzisti una forza d’occupazione nemica. Uno degli ufficiali, Tom Wilkin (Douglas Booth), diventerà il fidanzato di Shoshana, sfidando convenzioni e regole non scritte.
Di questo amore lei pagherà il prezzo più alto, come sempre o spesso capita alle donne, rischiando di fare la fine di altre ragazze colpevoli di “farsela con il nemico” e di essere ripudiata dal fratello integralista.
Winterbottom mette la relazione tra i due giovani a far da contrappunto al conflitto dal più ampio respiro storico, che in parallelo corre verso l’inevitabile inasprimento con, alla fine, l’avvio di una guerra strisciante a carattere ormai permanente in quella tormentata regione: Shoshana abbandonerà gli ideali socialisti del padre e imbraccerà le armi a fianco dei suoi compagni, contro popoli a loro volta vittime dei crudeli giochi imperialistici di un terribile ‘900.
Di seguito il trailer del film di Michael Winterbottom con Harry Melling e Douglas Booth in lingua italiana.